La poetica del fanciullino
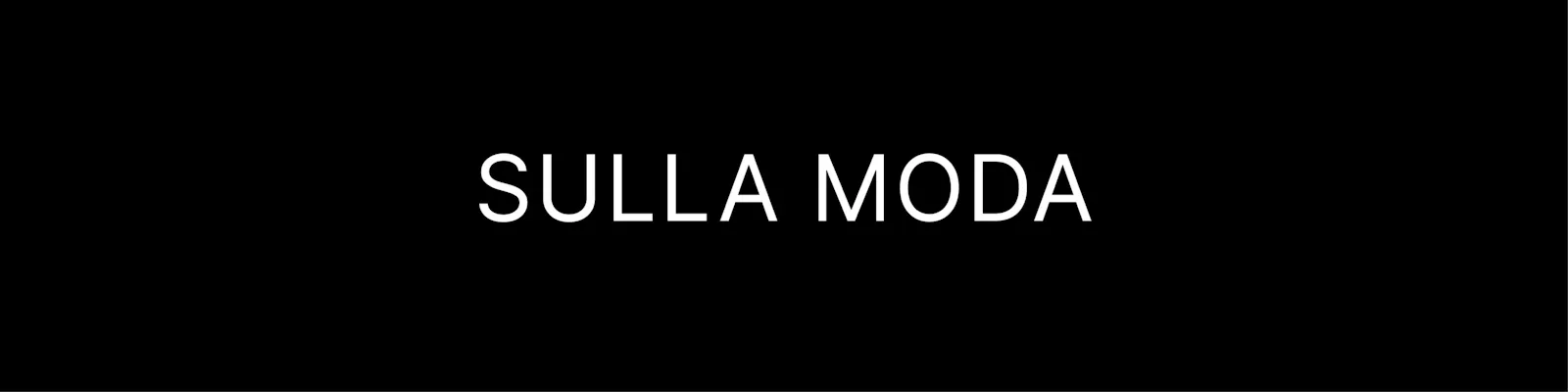
Che sia vissuto personale o approccio scientifico, un’innocenza bambinesca ha animato due sfilate agli angoli opposti del fashion system (quella di JW Anderson per Dior Homme e quella di Jacquemus). Perché niente accomuna la moda contemporanea come il rifiuto del futuro.
Da una parte, foto in bianco e nero di avi ritratti tra i campi, messe fianco a fianco con immagini speculari e ben più moderne, di campagne pubblicitarie realizzate per celebrare quell’età misteriosa e romanticizzata del passato, di tutto ciò che è esistito nel nostro albero genealogico ben prima del nostro arrivo; dall’altra un invito al rendez-vous fashionista assai elitario (solo 100 inviti, molti influencer adirati lasciati fuori, compreso il francese Lyas, che per sfregio ha organizzato con Meta un watch party collettivo in un bar di Parigi) a forma di piatto di ceramica con uova –ugualmente in ceramica. Il succedaneo artsy di un lavoretto in stile Art attack si fa in questo caso dichiarazione d’intenti, attesa della schiusura delle suddette uova, portatrici di una nuova era, o di un “recoding” come è stato definito.
Non potrebbero esserci due designer più diversi – per formazione, per geografia, per retaggio culturale - di JW Anderson, che ha finalmente debuttato da Dior, con la sua prima collezione dedicata all’abbigliamento maschile per la S/S 2026 e Simon Porte Jacquemus, che ha fatto invece sfilare nella seicentesca Orangerie di Versailles la sua collezione estiva (maschile e femminile) per il prossimo anno.
Eppure.
La sfilata di Jacquemus, intitolata Le paysan, ha convocato al consesso personaggi variegati come Matthew McCounaghey e signora (Camilla Alves), Gillian Anderson e Ghali, arrivati a Versailles per assistere a uno spettacolo al quale chi conosce l’epica del marsigliese Simon Porte è già abituato: la messa in scena dei suoi ricordi d’infanzia, la romanticizzazione di quel Mediterraneo antico e sensuale, dove l’unica colonna sonora è il frinire persistente delle cicale e quella della frutta raccolta dall’albero, le cui bucce si adagiano soavemente sull’erba. Le lenzuola tramate di broderie anglaise diventano gonne, le nappe da tendaggio sono decoro di pantaloni capresi, gli abiti con top bustier si arricchiscono di gonne plissé ricamate che ricordano atavici corredi, ripescati dal fondo dei bauli con la stessa solennità con la quale una volta, li si consegnava nelle mani di chi si avviava allo sposalizio, con la missione implicita di produrre altri corredi a propria volta, in un passaggio di consegne generazionale che si ripete uguale da millenni.

Un omaggio esplicito ai nonni che hanno creduto da subito in lui –con nonna presente e ovviamente emozionata–, che ha genericamente convinto la stampa (persino la solitamente severa Cathy Horyn, che sul The cut (Si apre in una nuova finestra) ha espresso la soddisfazione basica, diretta e genuina che si prova di fronte ad “abiti bellissimi, senza complicazioni”).
E in questo, in effetti, c’è la chiave del successo di un brand nato poco più di dieci anni fa, che è riuscito a rimanere indipendente – nonostante un’iniezione di denari da parte di L’Oréal, oggi socio di minoranza, allo scopo di sviluppare una linea beauty (Si apre in una nuova finestra)e, secondariamente permettere l’espansione del business con aperture di nuovi negozi. Nel 2022 c’è stata la prima boutique a Parigi, nel 2024 il brand è sbarcato in America con un negozio a SoHo (New York) a cui è seguito a febbraio 2025 quello a Los Angeles e un prossimo opening previsto a Miami. In tutto dieci boutique che garantiscono una presenza in capitali dello stile – ma anche nei luoghi di vacanza, come Ibiza o Capri – dove il gusto per il Mediterraneo di Jacquemus trova la sua piena espressione.
E certamente, come lo accusano i detrattori, parte del suo lavoro è derivativa: in alcune stagioni è sembrato guardare molto al Pieter Mulier di Alaia, in questa c’è stata la borsa a forma di verdura (il gambo di sedano l’ha realizzato qualche stagione fa Adriana Appiolaza da Moschino) e l’apertura della porta a inizio sfilata da parte di un bambino che doveva rappresentare il Simon Porte fanciullo (a febbraio, alla sfilata del centenario di Fendi, ad aprire un portone erano stati i nipoti della direttrice creativa Silvia Venturini Fendi, Tazio e Dardo, che indossavano lo stesso abito da lei sfoggiato quando, poco più che seienne venne scelta da Karl Lagerfeld come modella).

Il prodotto finale ha una qualità media, non paragonabile a quella che, si suppone, dovrebbe avere un brand del lusso: se diciamo “si suppone” è perché nell’ultimo anno le roboanti dichiarazioni sulla qualità artigianale dei prodotti delle maison sono state parzialmente sconfessate dagli accertamenti della Guardia di Finanza, facendo crollare la fiducia del cliente verso un mondo fatato al quale comunque non poteva accedere, per via dei prezzi schizzati alle stelle. I prezzi di Jacquemus sono invece raggiungibili da quel cliente aspirazionale che il lusso ha rigettato come figlio indesiderato (sul sito la borsa Il Chiquito è disponibile in una varietà di prezzi che va da 385 a 890, mentre i dress midi in maglia costano 590 euro). Di conseguenza, al netto di pregi e difetti, il suo successo commerciale è comprensibile, soprattutto perché con la sua comunicazione intelligente ha avuto il merito negli anni di intercettare un immaginario universalmente ambito, nel quale qualunque donna (ma anche uomo) sogna di giocare il ruolo del protagonista: quello del ritorno pacificato alle origini, laddove per le origini c’è un Sud del mondo, che può essere il Sud della Francia e dei suoi campi di grano (in alternativa ci sono anche i campi di lavanda della Provenza) o un’Italia assolata che si esperisce meglio dal tetto della casa di Curzio Malaparte, arroccata sul mare a Capri.
D’altronde, come Cesare Pavese faceva dire all’emigrante di ritorno Anguilla, protagonista de La luna e i falò, avere un paese al quale tornare vuol dire in fondo non essere mai soli, “sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”. Rivivere, insomma, la propria fanciullezza con la consapevolezza della maturità, e rimpiangere il romanticismo per tempi semplici, nei quali gli interrogativi avevano lo spessore di un foglio di carta sul quale immaginare con i pennarelli il proprio futuro.
E all’infanzia guarda anche il nordirlandese Jonathan Anderson, ma per motivi ben diversi: nel corso di tutta la sua carriera, con il suo brand eponimo e poi da Loewe, la sua cifra è sempre stata quella dell’approccio giocoso agli abiti, lo stesso che potrebbe avere un bambino, inconsapevole di censure e cesure a cui poi l’età adulta ti addomestica. Un modus operandi che ha utilizzato anche per il suo debutto da Dior Homme, dove l’abito Delft del 1948 di Christian Dior si trasforma in un pantalone cargo sovradimensionato, simile ad un origami. Il trattamento Anderson non ha risparmiato i papillon, giganteschi come quelli che disegnerebbe un bambino, omaggio all’eleganza francese, così come le scarpe dal sapore rétro, che ricordano nella silhouette i sandali di gomma da far indossare ai più piccoli al mare. I maglioni hanno romantici motivi floreali, dal minimalismo naïf, mentre i volumi architettonici della gonna de La Cigale, abito del 1952 considerato ad oggi vera e propria opera d’arte, si ripropongono in pantaloni cargo.
https://www.youtube.com/watch?v=7seI0u4cQ_I (Si apre in una nuova finestra)Sulle book tote lanciate originariamente da Maria Grazia Chiuri si stampano titoli di libri, dal Dracula di Stoker a Les Fleurs du Mal di Baudelaire, tingendo il tutto di tonalità prive di intermediazione, che appaiono scelte dall’astuccio dei colori di un frequentante della scuola primaria: rosa ciclamino, verde smeraldo (sulla cappa rifatta uguale a quella realizzata da Marc Bohan negli Anni 60), ma anche giallo acceso abbinato al rosso. Sprazzi vitaminici in un quadro altrimenti pacato, tinto di crema, variazioni di grigi, verde foresta e blu denim. Un lavoro sapiente che ha messo insieme giacche militari e sottogiacca imbottiti da tech-bro, con accenni preppy nelle cravatte regimental, altri al lavoro di Slimane (nelle cappe così come nella lingerie a vista), senza dimenticare la Bar Jacket, rivisitata per il corpo maschile. Un lavoro che smorza la serietà dell’evento con una certa gaiezza, ma che nulla ha di ingenuo.
L’aggettivo “cool” così spesso affibbiato a Jw Anderson, ritorna calzante: Anderson non ha soltanto il merito di creare oggetti che irradiano desiderabilità, e quindi coolness, capaci di far dialogare il popolare con la pop art (come nei riferimenti a Basquiat nel moodboard), ma ha dalla sua la freddezza – in inglese, coolness – che si attribuiva ai jazzisti di cool jazz, un approccio controllato, più raffinato rispetto al precedente e indiavolato bebop. E con quella freddezza registica, mette in scena uno studiato spettacolo, dove il modus operandi fanciullesco è arma tramite la quale muoversi con grazia nel campo minato della complessità dell’oggi, evitandone le asperità. Perché, pur essendo molto distanti sia JW Anderson che Simon Porte sono ben consapevoli che nel 2025 non c’è compito più ingrato che provare a immaginare il futuro.
We are the fashion pack
Prada è incappata in un caso di appropriazione culturale (Si apre in una nuova finestra), ma avendo a disposizione probabilmente un dipartimento di crisis management che funziona, ne è già uscita in serenità
Chi di crisis management ne avrebbe disperatamente bisogno, è invece Max Mara (Si apre in una nuova finestra)
La vincitrice dell’Andam Prize (che si porta a casa 300 mila euro) è Meryll Rogge (Si apre in una nuova finestra): sentiremo parlare di lei
La prima mostra personale di Glen Luchford – fotografo ad oggi amatissimo da tutte le maison che contino qualcosa – arriva a settembre (Si apre in una nuova finestra) a 10 Corso Como
Se Gucci ha Sinner, Bottega Veneta ha Musetti (Si apre in una nuova finestra): pari e patta, si dice da me.
The tortured audio visivo department
The Devil Wears Prada 2 è ancora lontano ma intanto è arrivato un primo (Si apre in una nuova finestra)brevissimo trailer
Amici delle serie crime, è il momento di sintonizzarvi su Netflix per recuperare Department Q, prima di ora
Rolling Stone fa la lista delle migliori serie del 2025 (Si apre in una nuova finestra) sino ad ora: sbizzarritevi
Il New York Times è andato oltre e ha stilato la lista dei 100 film migliori del 21esimo secolo (Si apre in una nuova finestra): non vedo Sorrentino, quindi non sono già d’accordo