Cosa vuol dire, oggi, fare il critico di moda
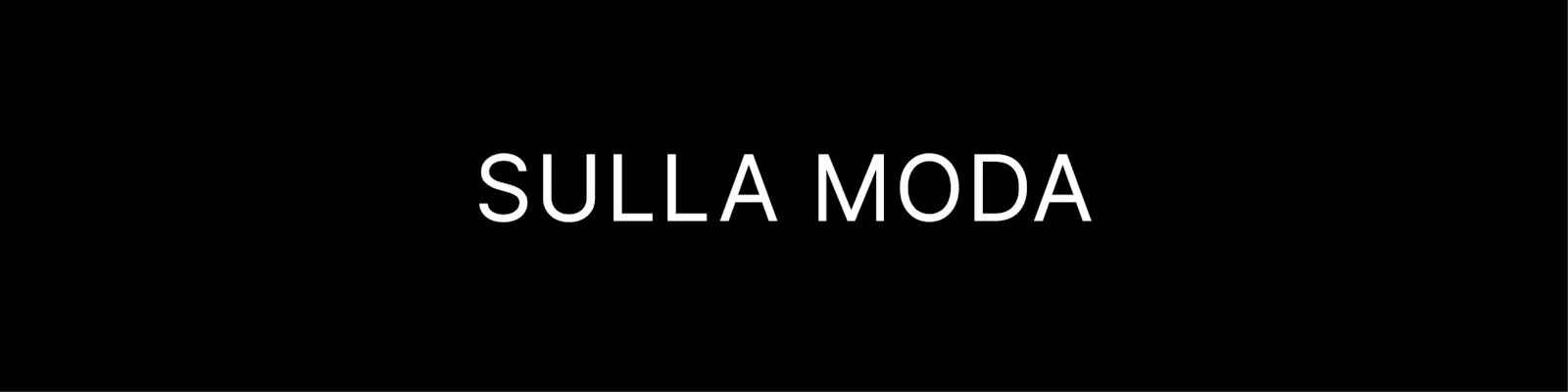
E perché chiamarsi “influencer” non è più considerato desiderabile da nessuno (neanche dagli influencer)
Quando, qualche settimana fa, il New York Times ha scritto questo pezzo (Opens in a new window), ha definito Elias Medini, 26enne commentatore di moda non invitato al debutto di Jw Anderson da Dior e però capace di organizzare un “Watch party” affollatissimo in un bar di Parigi, un “critico di moda”. La giornalista del Washington Post Rachel Tashjian – una professionalità che è canonicamente definibile come “critica di moda” – ha riportato il pezzo tra le sue stories di Instagram, scrivendo “Amo i content creator e gli influencer ma non credo che dovresti definirti critico di moda se il designer ti regala una borsa per ringraziarti della copertura mediatica”. (In seguito all’evento, il content creator è stato invitato da Jw Anderson nello show-room di Dior per vedere la collezione e ha ricevuto una borsa in regalo, ndr).
Un commento che va al cuore di un problema, se è così definibile, e che riguarda in maniera generica il veloce modificarsi dei ruoli all’interno del mondo della comunicazione e dell’editoria. Un processo che è iniziato negli anni del Covid, quando, senza eventi ai quali partecipare, viaggi o sfilate da mostrare sul proprio feed, gli influencer classici si sono trovati in una situazione di impasse. In quel momento si sono fatti strada quelli che oggi definiamo comunemente content creator, personalità capaci di raccontare la moda (e moltissimi altri argomenti), attraverso diverse forme – video TikTok, lunghi post, persino sketch comici. Per ovviare a tutte le restrizioni e le limitazioni di quel momento, così come alla domiciliazione forzata, era divenuto necessario essere dei comunicatori abili, anche se privi del glamour degli influencer classici: in realtà, proprio l’artigianalità iniziale dei mezzi di produzione portava il pubblico a essere più bendisposto verso questa nuova categoria, in quanto ne testimoniava l’onestà intellettuale, la lontananza da un mondo già percepito come elitista, disinteressato al confronto con la realtà, ossessionato dal mantenere per sé i propri privilegi, quello che in inglese si definisce “gatekeeping”, un controllo attento di chi e come può accedere all’interno dei suoi palazzi dorati.
Il caso Ferragni-Pandoro risalente al 2022, divenuto quest’anno una traccia dell’esame di maturità (Opens in a new window) in Tunisia ha assestato un colpo d’immagine (quasi) fatale alla categoria, e, di conseguenza, il termine “influencer” si è tramutato gradualmente in uno status peggiorativo, anche perché divenire un influencer – al netto della buona volontà delle maison, che dedicavano e dedicano una sostanziosa parte dei loro investimenti pubblicitari alla collaborazione con queste figure – si era fatto più difficile. Gli algoritmi di Instagram non favorivano più crescite subitanee a colpi di “Outfit of the day” e su TikTok o YouTube i contenuti premiati e premianti erano quelli capaci di fornire informazioni, raccontare stilisti o collezioni con espressioni che andassero oltre l’ “amazing” di rito, magari anche ironizzando sulla tossicità del sistema a suon di meme. Di conseguenza sono nate figure ibride, la cui autorevolezza era proprio data dal loro essere dichiaratamente fuori da quel sistema di do ut des.
Profili come quello di Ideservecoture o quello di Lyas (nom de plume di Elias Medini, ndr) ricadono in questa casistica. Siccome “the devil works hard but fashion works harder” i dipartimenti di comunicazione delle principali maison hanno da subito intercettato questa tendenza e, da anni in crisi di autorevolezza, hanno visto in queste figure – che, cautamente, hanno sempre evitato di definirsi fashion critic, optando per definizioni meno divisive, come “fashion commentator” o “fashion narrator” – una desiderabile cassa di risonanza, un’evoluzione migliorativa della vecchia figura dell’influencer, a cui era necessario abbinarsi. Di conseguenza, hanno aperto loro le porte, invitandoli alle sfilate e regalando loro prodotti – come si fa con gli influencer –nella speranza che, grati di quell’accesso, con la possibilità di vedere capi ed eventi dal vivo, stringere rapporti commerciali con i brand stessi, inserirsi insomma in quei circoli a cui inizialmente si dicevano orgogliosi di non appartenere, si sarebbero convinti a più miti consigli. Un epilogo che, nella maggior parte dei casi, c’è stato: account come quello di Stylenotcom, nati con una cornice grafica subito riconoscibile e accattivante, dediti a fornire informazioni basiche su sfilate e progetti dei brand – un obiettivo con una sua dignità –, a suon di collaborazioni pagate e introduzione in un sistema solitamente chiuso, sono divenuti un vanity project nel quale alla moda piace specchiarsi, mentre gli altri, letteralmente, restano a guardare. In fondo, a quanti utenti al di fuori degli addetti ai lavori può davvero interessare se oggi è il compleanno di tal redattore moda o se il pr di Prada ha sfoltito le sue lunghe chiome? A dimostrazione del massivo successo dell’account è nato anche un profilo assai simile nell’impostazione grafica (con il verde acido al posto del blu) e un nome che è una dichiarazione d’intenti: Boringnotcom. L’approccio è qui però molto più critico, e non risparmia stilettate a campagne pubblicitarie o collezioni che vengono considerate non particolarmente riuscite.
Il sistema della moda è quindi riuscito ad “addomesticare” e inglobare al suo interno voci che, pure se non apertamente critiche, erano nate con l’obiettivo di offrire informazioni e prospettive dotate di una certa personalità? Probabilmente si tratta di una situazione momentanea: se è certo che gli influencer o i content creator in una qualche forma, esisteranno sempre –e non vi è nulla di male in personalità che si fanno incarnazione di questa o quell’altra maison, capaci di attrarre con la loro epopea personale e il loro punto di vista sulle cose del mondo follower e investimenti–, la velocità dell’evoluzione tecnologica, dei sistemi di comunicazione odierna dei social in generale, consente un ricambio veloce. Non è improbabile quindi che in un futuro assai prossimo nasceranno nuovi fenomeni spontanei, slegati dai sistemi editoriali, un “citizen journalism” capace di avere un rapporto equidistante con i brand, soprattutto se il fashion system continua ad essere così profondamente in crisi di autorevolezza e incapace di rispondere in maniera organica, collettiva, alle critiche e agli scandali che sembrano ultimamente travolgerlo.
Il problema più grave, secondo Emanuele Coccia, filosofo e professore associato all’ École des hautes études en sciences sociales di Parigi, risiede con la difficoltà persistente che ha la moda con la critica giornalistica, in generale.
Il discorso critico sulla moda non è stato mai sviluppato. A dire la verità, la moda ha almeno quattro problemi con la critica. In primo luogo, viene tollerato che si scriva o si dica che la moda non sia un’arte. Pensa cosa succederebbe se un architetto o un’architetta dicesse che non si tratta di un’arte: una simile affermazione verrebbe subito denunciata per quello che è, una forma molto grossolana di cinismo che dimostra non certo “radicalità” ma solo una imbarazzante ignoranza.
Per via di questo cinismo, tranne qualche rarissima eccezione (quella di Alessandro Michele) le case di moda non si sono mai preoccupate di elevare il proprio e l’altrui discorso sull’arte che praticano. Non solo la maggioranza delle case scrive testi e pubblicano libri che sembrano indirizzarsi a degli analfabeti, ma pretende anche che quello che si scriva sulla moda sia a livello di studi elementari. Nessuna complessità, pochissima profondità storica, nessun tentativo di articolare l’opera in un contesto più ampio.
In parte questa assenza di complessità deriva dalla mancanza di educazione sulla storia della moda, che non è insegnata in quasi nessuna università. Del resto una delle cose più strane del modo in cui la moda è insegnata è che non fa quasi mai parte dei dipartimenti di design (penso agli Stati Uniti), ma sempre ghettizzata in luoghi e facoltà autonome. Non si prende mai in considerazione che la storia della moda dovrebbe essere conosciuta da chiunque così come la storia della pittura o la storia dell’architettura.
In parte questa responsabilità ricade però anche sulle case di moda. Basta un paragone con le gallerie a dimostrarlo: qualsiasi galleria produce e paga letteratura critica sui propri prodotti il cui scopo non è l’esaltazione acritica dell’opera ma la sua consolidazione in un panorama autonomo che non ha bisogno di ridurre il discorso a tifo da stadio.
Le case sembrano invece ancora pensare la comunicazione in termini ottocenteschi: come se il punto fosse scrivere davvero sinonimi di ‘comprate questo oggetto’ invece di descrivere, pensare, rendere l’oggetto intelligibile e intellettualmente desiderabile.
C’è una sorta di paura per la parola, e paura per la complessità. E anche, infine, una idea abbastanza antiquata di commercio e economia.
Secondo Coccia, quindi, la moda ha tutto l’interesse ad elevare a “critici” pareri che in realtà vengono spesso da partner commerciali, e quindi, ovviamente, influenzati (in maniera consapevole o meno) da un rapporto di collaborazione passato o presente. Uno scambio economico che richiede a sua volta, da parte dell’utente finale, quella che il poeta Samuel Taylor Coleridge definiva già “sospensione dell’incredulità”.
Certo, anche i giornalisti lavorano per delle istituzioni culturali con scopo di lucro che hanno tra gli investitori e principali finanziatori proprio i brand di moda: a fare da filtro tra giornalisti e maison, nel caso dei giornali, garantendo a chi scrive una sana indipendenza di pensiero – soprattutto laddove ci siano in ballo progetti di collaborazione tra i due, come succede ad esempio nel caso degli shooting monografici –sono però i tanto vituperati ma utili reparti marketing, che si interfacciano direttamente coi brand, e la figura del market editor, il cui obiettivo è proprio quello di rendere scorrevole la conversazione tra giornalisti/redattori e brand, facendo da mediatore tra le esigenze degli uni e degli altri, senza che i due debbano necessariamente incontrarsi. Quanto sopra è ciò che accade spesso nei paesi anglofoni, dove il pensiero critico giornalistico, anche riguardo alla moda, è tenuto in grande considerazione, prima di tutto dalle stesse redazioni dei giornali, che non vedono nella sezione moda una cifra minoritaria, utile solo a raccogliere investimenti pubblicitari: l’unica giornalista di moda ad aver vinto un Pulitzer per la critica nel 2006 è stata proprio una collega di Tashjian al Washington Post, Robin Givhan, per via di “saggi arguti ed oculati che trasformano la critica di moda in critica culturale”, come da motivazioni ufficiali del comitato del Pulitzer. In Italia si fa ancora molta fatica a concedere alla critica di moda la stessa autorevolezza, spesso la si equipara a un postribolo delle peggiori frivolezze femminili, ma anche le più stolide convinzioni, con il tempo possono cambiare.
Questo non significa certo che dovremo smettere di seguire le vicende dei nostri content creator preferiti, interagire sui loro profili, partecipare agli eventi che organizzano, gioire dei loro successi come fossero i nostri, ammirarne i look e cercare di replicarli, comprare i prodotti che ci consigliano o le colab che realizzano con i brand: l’internet, e più in generale anche il mondo reale di questi anni è un posto che regala poche occasioni per astrarsi dalle proprie quotidiane preoccupazioni. Ogni occasione per provare un barlume di leggerezza, grattare una scheggia di entusiasmo da quegli schermi liquidi di solito portatori di angosce e ansie esistenziali, è bene accetta, anzi, di più: vitale. L’importante è considerarla per quello che è: una forma di intrattenimento, con occasionali spot pubblicitari.
Soundtrack ufficiale della settimana
https://www.youtube.com/watch?v=K0siYUjV9UM&list=RDK0siYUjV9UM&start_radio=1 (Opens in a new window)Mama, he’s coming home.
Ciao Ozzy.